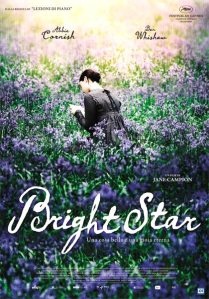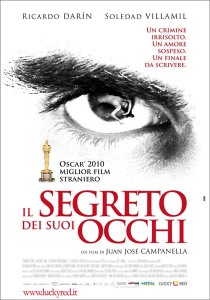A Nazaret, una badante filippina fa karaoke sulla canzone del Titanic – quella di Celine Dion – per dilettare la sua anziana “assistita”, che è un’araba israeliana. E il regista, Elia Suleiman, guarda stupefatto la scena assieme allo spettatore. È l’immagine più teneramente grottesca de Il tempo che ci rimane, in concorso a Cannes nel 2009 e uscito al cinema solo poche settimane fa. Che cos’è la guerra? Che cosa sono i conflitti, quando in realtà le persone si mischiano e convivono per altre vie? Quando nella realtà i bambini arabi cantano sorridenti le canzoni ebraiche perché alla fine la cosa che gli piace sul serio è cantare (e chi se ne importa quale sia la canzone, se americana, araba, filippina o israeliana)?  Composto da quattro “episodi”, Il tempo che ci rimane racconta la minoranza non ebrea d’Israele attraverso la vita del padre e della madre del regista. Omaggio ai genitori e tentativo – impossibile – di ricostruirne la memoria, i quattro quadri in cui è composto il film, ondivago e suadente, si susseguono per salti temporali e senza una trama precisa. Forse perché, per chi come il regista è nato negli anni 60, l’unico modo per ricomporre i pezzi di un conflitto ormai inestricabile è ripensare alla propria famiglia, alle biografie di chi è nato prima del 1948. Il film perciò non può che porsi “a distanza” e per farlo il regista usa, come anche nel precedente Intervento divino, un registro comico e spaesante. Gli strumenti principali di questa peculiare comicità (per cui Suleiman è spesso paragonato spesso a Tati) sono le ripetizioni (il maestro che “sgrida” il piccolo protagonista) e i tormentoni che segnano una progressione narrativa (il vicino di casa che si vuole dare fuoco o la “pesca” notturna), i personaggi pressoché muti (il padre e lo stresso Elia) che conosciamo solo attraverso le azioni, gli episodi potenzialmente tragici che virano nell’assurdo, la staticità delle scene spesso scrutate con stupore dal regista che ironicamente entra nelle inquadrature. Il tutto per dipingere un mondo che talvolta è incomprensibilmente vivo in mezzo al disastro e talvolta sembra una natura morta cristallizzata nel tempo che scorre (la madre vecchia sulla terrazza).
Composto da quattro “episodi”, Il tempo che ci rimane racconta la minoranza non ebrea d’Israele attraverso la vita del padre e della madre del regista. Omaggio ai genitori e tentativo – impossibile – di ricostruirne la memoria, i quattro quadri in cui è composto il film, ondivago e suadente, si susseguono per salti temporali e senza una trama precisa. Forse perché, per chi come il regista è nato negli anni 60, l’unico modo per ricomporre i pezzi di un conflitto ormai inestricabile è ripensare alla propria famiglia, alle biografie di chi è nato prima del 1948. Il film perciò non può che porsi “a distanza” e per farlo il regista usa, come anche nel precedente Intervento divino, un registro comico e spaesante. Gli strumenti principali di questa peculiare comicità (per cui Suleiman è spesso paragonato spesso a Tati) sono le ripetizioni (il maestro che “sgrida” il piccolo protagonista) e i tormentoni che segnano una progressione narrativa (il vicino di casa che si vuole dare fuoco o la “pesca” notturna), i personaggi pressoché muti (il padre e lo stresso Elia) che conosciamo solo attraverso le azioni, gli episodi potenzialmente tragici che virano nell’assurdo, la staticità delle scene spesso scrutate con stupore dal regista che ironicamente entra nelle inquadrature. Il tutto per dipingere un mondo che talvolta è incomprensibilmente vivo in mezzo al disastro e talvolta sembra una natura morta cristallizzata nel tempo che scorre (la madre vecchia sulla terrazza).
C’è totale distonia tra le esistenze e la “Storia”. E Suleiman la rende evidente attraverso le scelte stilistiche, non attraverso il plot. Perché l’obiettivo – centrato – è gettare lo spettatore in un universo visivo depistante. Per cui a Ramallah i giovani amano la tecno e si scatenano in discoteca (ma la gag del carrarmato che “mira” al giovane palestinese mentre butta la spazzatura è eccellente) e una donna con il passeggino è più rivoluzionaria di una sassaiola. Suleiman osserva l’umanità che imperterrita continua a vivere. Come se, appunto, i conflitti siano generati da “soggetti” non inquadrabili perché astratti (gli stati, la politica) ma non delle persone, né dei singoli soldati che magari hanno anche perso la  strada, come accade al miliziano palestinese all’inizio del film (e ancor di più al tassista, nella notte). L’artificiosità degli interni, con case belle e curate, le simmetrie e le opposizioni visive, gli elementi “coreografici” – i domestici dell’anziana madre che danno lo straccio, o l’andirivieni degli ospiti del pronto soccorso – sono tutti segni dispersi che restituiscono l’irrealtà emotiva di una situazione di fatto, quella del conflitto. Una situazione che lo stesso regista non riesce a comprendere.
strada, come accade al miliziano palestinese all’inizio del film (e ancor di più al tassista, nella notte). L’artificiosità degli interni, con case belle e curate, le simmetrie e le opposizioni visive, gli elementi “coreografici” – i domestici dell’anziana madre che danno lo straccio, o l’andirivieni degli ospiti del pronto soccorso – sono tutti segni dispersi che restituiscono l’irrealtà emotiva di una situazione di fatto, quella del conflitto. Una situazione che lo stesso regista non riesce a comprendere.
Il fulcro del film, attorno a cui ruotano tutti gli eventi, sono perciò i genitori: il padre Fuad caparbiamente dedito alla causa palestinese e la madre, dolce quanto “di polso”. È la loro presenza a rendere il racconto non solo vividamente autobiografico, ma soprattutto molto molto amaro. La loro morte pare chiudere ogni possibilità di racconto ulteriore. Come se, con la fine della generazione dei padri, fosse finita anche la possibilità di decifrare cos’era la Palestina, da dove si viene e perché si combatte. A questo punto, con sguardo fatalmente triste, il regista sembra pensare che l’origine è smarrita e nel “tempo che rimane” per oltrepassare la guerra forse non resta che saltare a piè pari il muro che divide i popoli. Per non smarrirsi nella notte che ancora, assurdamente, avvolge tutti.
Il tempo che ci rimane (The Time That Remains), di Elia Suleiman, GB/Italia/Belgio/Francia, 2009, 105 minuti
Cast: Elia Suleiman, Saleh Bakri, Samar Qudha Tanus, Shafika Bajjali, Tarek Qubti, Zuhair Abu Hanna, Ayman Espanioli, Bilal Zidani, Leila Mouammar, Yasmine Haj, Amer Hlehel, Nina Jarjoura, Georges Khleifi, Ali Suliman
Distribuzione: Bim
Uscita in Italia: venerdì 4 giugno 2010.